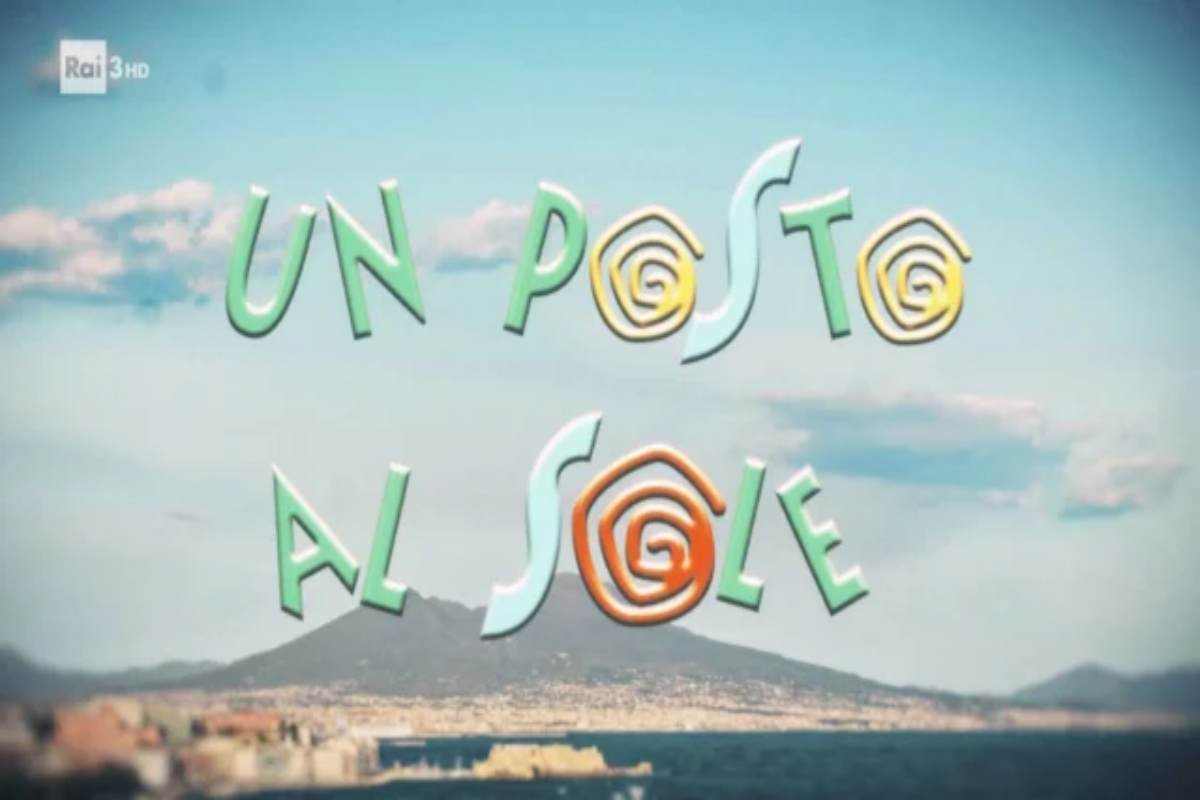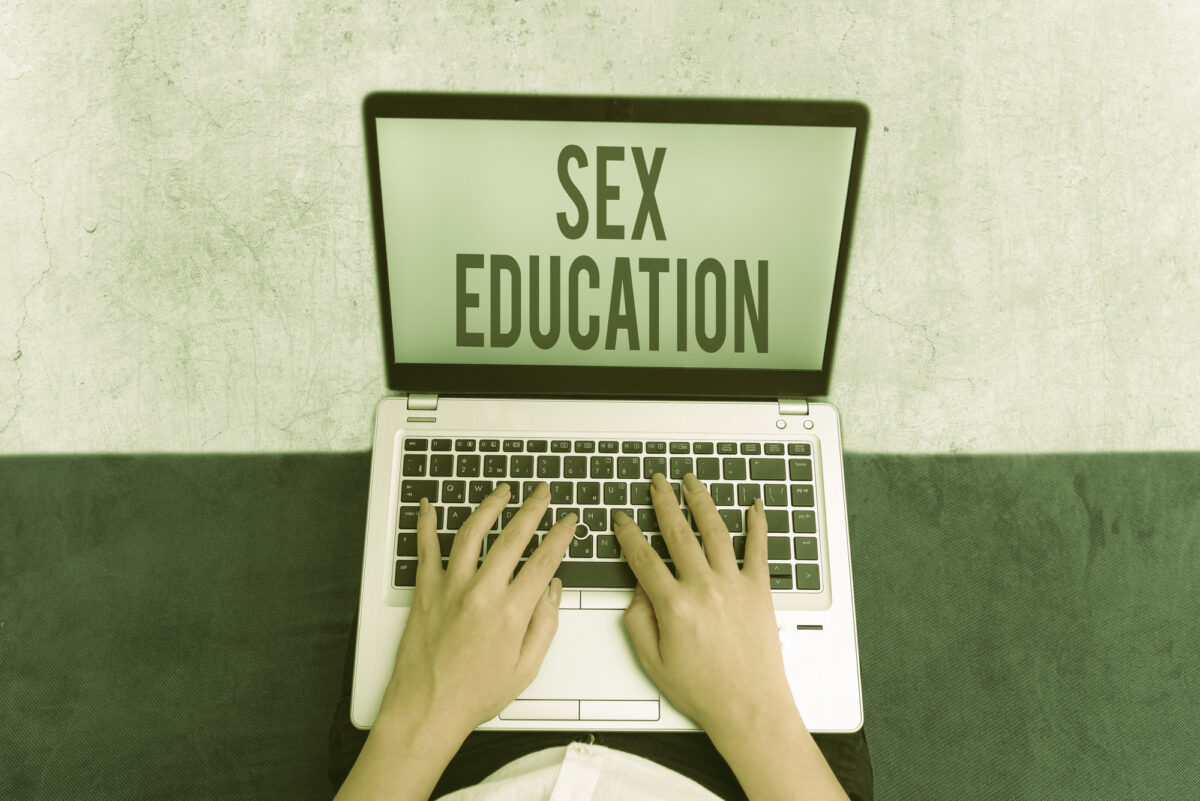In Italia esistono già diverse forme di tassazione patrimoniale: IMU, successioni, bollo e imposte sui capitali incidono per 40 miliardi l’anno.
In Italia il tema della tassa patrimoniale riemerge puntualmente ogni volta che si avvicina la manovra economica. Anche in autunno 2024 la discussione è tornata centrale dopo la proposta della Cgil, che ha avanzato un prelievo dell’1,3% sui patrimoni oltre i due milioni di euro, aprendo un confronto acceso tra Governo, sindacati e opposizioni. Il punto, però, è che una patrimoniale “nuova”, strutturata come imposta straordinaria sui grandi capitali, non è mai stata introdotta. Eppure forme di tassazione patrimoniale già esistono, da anni, con un impatto economico che spesso si tende a sottovalutare. Un quadro ricostruito anche nella puntata del programma Numeri, in onda su Sky TG24 il 10 novembre 2024, che ha analizzato cosa si paga davvero oggi e quanto vale per lo Stato questa categoria di imposte.
Le patrimoniali già presenti nel sistema italiano
Quando si parla di patrimoniale molti pensano a un prelievo improvviso e straordinario. Ma nel sistema fiscale italiano una serie di imposte ricadono già nella categoria delle patrimoniali, perché colpiscono il possesso di un bene e non il reddito prodotto da quel bene. La più rilevante per gettito è l’IMU sulle seconde case: si paga indipendentemente dall’affitto, dal valore locativo o da una rendita. È un’imposta fondata sul semplice fatto di possedere un immobile, e non a caso rappresenta una delle voci più consistenti per i Comuni.

Accanto all’IMU, il sistema include il bollo auto, l’imposta di bollo sui conti e strumenti finanziari, l’imposta di registro, fino alle tasse di successione che colpiscono eredità e trasferimenti di ricchezza. Già questo elenco chiarisce come l’Italia non sia affatto un Paese privo di patrimoniali. La differenza rispetto ad altri Stati europei riguarda l’intensità e la struttura di queste imposte, non l’esistenza in sé.
Uno dei dati più significativi riguarda proprio le successioni. Nel 2024 lo Stato ha incassato circa 1 miliardo di euro dalle imposte ereditarie, una cifra molto più bassa rispetto ad altri Paesi comparabili. In Spagna il gettito sale a 3,5 miliardi, in Germania a 7 miliardi, nel Regno Unito sfiora i 9,5 miliardi, mentre in Francia arriva addirittura a 17 miliardi. Un divario che nasce da differenze enormi nel prelievo. In Italia, ad esempio, un figlio che eredita 2 milioni di euro paga circa 40mila euro. Lo stesso erede, in Germania, si troverebbe a versare 304mila euro. In Francia la cifra salirebbe a 617mila, nel Regno Unito a quasi 670mila euro. Paradossalmente, negli Stati Uniti non pagherebbe nulla, ma solo perché l’imposta scatta oltre soglie molto alte.
Ancora più evidente il distacco prendendo un’eredità da 100 milioni di euro lasciata a una persona senza legami familiari: in Italia si pagano 8 milioni, negli Stati Uniti 35, nel Regno Unito 40, in Germania 49, in Francia 60 milioni. Dati che mostrano come il peso fiscale sulle grandi ricchezze, nel nostro Paese, sia decisamente più leggero rispetto al Nord Europa.
Nel 2024, considerando tutte le imposte patrimoniali presenti, l’Italia ha incassato circa 40 miliardi di euro su un totale di 700 miliardi di gettito complessivo. Una quota minoritaria ma non trascurabile. È proprio questa somma che spesso riaccende il dibattito politico: quanto si dovrebbe chiedere ai grandi patrimoni? È sufficiente ciò che già esiste? E soprattutto, una patrimoniale aggiuntiva sarebbe compatibile con il quadro economico attuale?
Il nodo politico: perché la patrimoniale divide (e perché non è prevista nella manovra)
La proposta avanzata dalla Cgil, stimata in 26 miliardi di gettito potenziale, si inserisce in un contesto politico in cui il Governo ha già dichiarato la sua contrarietà a nuove patrimoniali. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, anche in questa fase, ha ribadito che «con noi patrimoniali non ce ne saranno», riaffermando una linea di continuità con le promesse fatte sin dalla campagna elettorale del 2022. Il motivo è evidente: una patrimoniale strutturata sarebbe vista da una parte dell’elettorato come una tassa sui risparmi, con il rischio di spaventare investitori e famiglie con patrimoni medio-alti.
La discussione, però, non riguarda solo la volontà politica. Gli economisti ricordano che le patrimoniali straordinarie hanno un impatto delicato: da una parte generano risorse immediate, dall’altra possono innescare movimenti di capitale o spinte a ricollocare investimenti fuori dall’Italia. È un equilibrio complesso che il Governo, già impegnato nella costruzione della manovra 2025-2026, ha scelto di non toccare. La patrimoniale resta quindi un’ipotesi teorica più che una misura concreta.
Il confronto tra Italia ed Europa, intanto, continua a segnare un punto fermo: una tassazione patrimoniale esiste già, pesa per una quota definita del bilancio pubblico, e resta uno dei temi più sensibili del dibattito politico italiano. Che venga ampliata, riformata o mantenuta così com’è, sarà uno dei nodi che torneranno inevitabilmente nel prossimo ciclo legislativo.