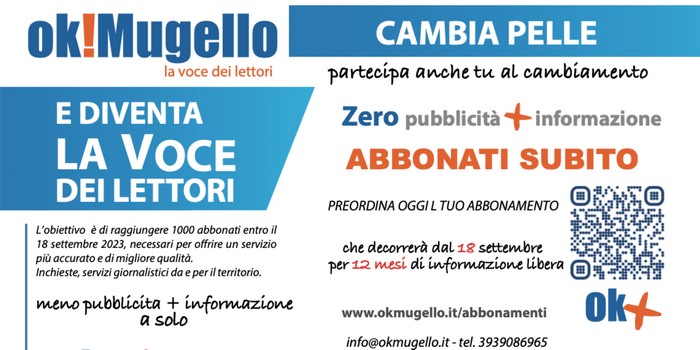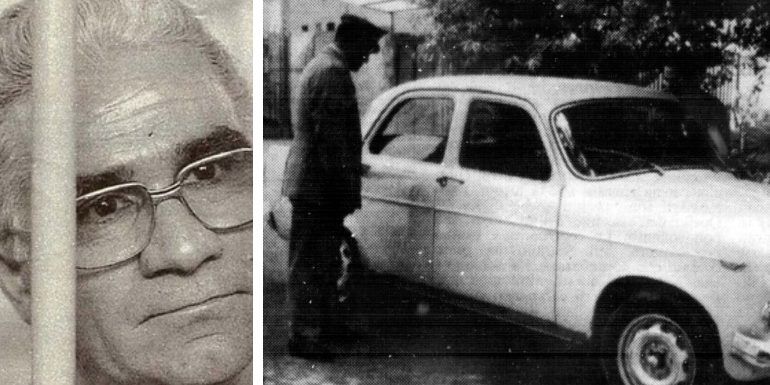Gender gap anche nel giornalismo © depositphotos
Gender gap anche nel giornalismo © depositphotos
All'indomani della giornata mondiale per l'eliminazione della violenza contro le donne al di là dei terribili fatti di cronaca nera fatta di femminicidi e violenza fisica resiste il soffitto invisibile di un'altra forma di violenza più subdola ma determinante: quella sociale ed economica.
Questa volta voglio lavare in piazza i panni della nostra categoria dato che anche nelle redazioni c'è
una contraddizione che le attraversa.
Le giornaliste sono molte, ma quando si guarda alle stanze del potere in cui si decide l’agenda mediatica, la presenza femminile si assottiglia.
Provo quindi con questo approfondimento a leggere le cifre, a raccontare le storie per far capire perché anche il giornalismo, al di là delle belle parole fatica a trasformare la propria promessa di inclusività in pratica.
Nel nostro settore si proclama molto l’importanza della pluralità. La notizia ha bisogno di punti di vista diversi per essere completa, eppure le stesse redazioni spesso non riflettono quel mondo nella loro composizione di potere.
Il dato come accennato in prefazione è semplice e netto: le donne costituiscono ormai una porzione significativa della forza lavoro giornalistica in Italia - attorno al 40–45% in molti rilevamenti - ma la loro presenza nelle direzioni e nei ruoli decisionali è ben più bassa.
Da ricerche internazionali e indagini nazionali emergono percentuali che oscillano fra il 24% e il 27% per i ruoli editoriali senior e in Italia, da report recenti si contano solo poche direttrici riconosciute tra i grandi quotidiani.
Questo divario non è neutro. E noto che laddove si decide l’agenda, chi chiamare in studio, quali inchieste finanziare, quali storie ottenere per un'apertura c’è sempre un filtro di potere. Se quel filtro è prevalentemente maschile, la selezione delle fonti, il tono del racconto e persino l’attenzione verso certe problematiche rischiano di rispecchiare un’unica prospettiva.
Basta guardarsi solo intorno ed osservare le statistiche sulle fonti degli esperti/esperte, la composizione dei panel ai dibattiti, tavole rotonde e talk show. Le donne sono spesso sotto-rappresentate come voci tecniche e analitiche, mantenendo uno stereotipo per cui sono più “adatte” a temi "leggeri e frivoli"del lifestyle o della cronaca rosa.
Vi sono poi aspetti subdoli e meno misurabili che incidono come la paura di essere attaccate online, la pressione della reperibilità permanente e la precarietà contrattuale che colpiscono, guarda strano, in modo più marcato le giornaliste.
Le minacce e il “female abuse” in rete le costringono se non ben strutturate emozionalmente a misure di sicurezza, ad auto-censura o addirittura ad abbandonare temi scomodi.
Questo effetto corrosivo non è solo personale: è un fattore che altera la qualità stessa dell’informazione.
Le ragioni del divario sono molteplici e intrecciate: stereotipi di genere ancora radicati, modalità organizzative del lavoro giornalistico non conciliabili con i carichi familiari e una cultura manageriale obsoleta.
A queste si sommano i meccanismi economici: le donne molto spesso, anche nel giornalismo, guadagnano meno, hanno contratti più fragili e meno sicurezza pensionistica, tutti elementi che limitano la capacità di ambire ai ruoli apicali.
Eppure non mancano segnali di speranza per guardare al bicchiere mezzo pieno.
In Italia e all’estero testate che adottano policy attive di parità e pratiche editoriali inclusive mostrano miglioramenti concreti.
Nuove forme di giornalismo — podcast, newsletter indipendenti, testate digital native — sono spesso guidate da donne che reinventano il mestiere su termini diversi.
Questi spazi danno opportunità e visibilità, ma non sono ancora in grado di sostituire la forza di cambiamento che produce la presenza nelle grandi redazioni e nelle direzioni, anche e soprattutto dal punto di vista dell'indipendenza economica.
Veniamo ai numeri. Quante sono le donne direttrici di testata in Italia?
Pochissime. anche se lo ribadiamo le donne hanno già dimostrato che sanno raccontare il mondo con rigore e originalità. È una questione di giustizia, ma anche di qualità democratica: un’informazione più paritaria è un’informazione migliore.
Il gender gap nel giornalismo italiano
Per quello che concerne la presenza complessiva nelle redazioni: le donne rappresentano circa il 42% dei giornalisti attivi in Italia
Le donne occupano però solo tra il 24–27% dei ruoli editoriali di vertice nelle testate (dati internazionali comparativi; progressi lenti: 23% nel 2020 → 27% nel 2025). Questo valore si rispecchia anche nello scenario italiano dove la presenza femminile ai posti di comando resta bassa.
Analisi recenti mostrano e confermano che solo poche testate nazionali sono dirette da donne (report e analisi nazionali indicano tra 2 e 5 direttrici su un campione di decine di quotidiani) e che su 38 direzioni complessive solo 6 sono guidate da donne e su 9 testate televisive (TG) non c'è nemmeno una direttrice.
Nonva meglio per quello che riguarda gli "esperti". Anche qui il dato è preoccupante: solo circa il 12% degli “esperti” ascoltati nei media italiani è donna. Ciò indica che, anche quando le giornaliste sono presenti, le voci autorevoli rimangono prevalentemente maschili.
Da segnalare anche che le donne sono sottorappresentate nelle rubriche “hard news” (politica, economia, cronaca internazionale, sport) e sovrarappresentate nei temi “soft” (cultura, lifestyle, costume).
Infine va segnalato che le giornaliste subiscono un numero maggiore di attacchi, minacce e molestie online rispetto ai colleghi maschi e questo fattore ha impatto su libertà professionale e sicurezza personale (rilevazioni internazionali e inchieste giornalistiche).
Fonti (Reuters Institute / IFJ, FNSI, AGCOM, DataMediaHub e indagini giornalistiche).
Escursus storico essenziale delle donne nel giornalismo italiano
Vale la pena guardare a un escursusu storico per dimostrare come anche nel settore l'arretratezza regni sovrana.
Fra la fine XIX e l'nizio XX secolo compaiono le prime firmatarie di articoli. Sono spesso legate a riviste femminili..
Anni ’20 –’30: La presenza femminile è ancora marginale. Compaiono le prime croniste e firme su temi “femminili” o culturali.
Dopoguerra (anni ’50 – ’60): E' lento l'ampliamento di presenza femminile nelle redazioni, soprattutto nella stampa locale e nella radio. I ruoli direttivi sono quasi inesistenti.
Anni ’70 – ’80: Gli anni di piombo dopo le ondate femministe e la riforma culturale favoriscono l’ingresso di più donne nelle redazioni e la nascita di testate e colonne dedicate a diritti e società.
Anni ’90:. Arrivano le prime editorialiste e firma donne di rilievo nazionale. Sono ancora pochissime le direttrici nei grandi quotidiani.
2000 – 2010. Aumento della presenza femminile nelle professioni giornalistiche. Compaiono le prime donne in ruoli di rilievo nelle televisioni e in ruoli manageriali minori.
2010–2020: La presenza femminile nelle redazione è solida (attorno al 40% in molti mercati), ma il soffitto rimane: poche direzioni, poche posizioni di potere.
2020–2025: Studi internazionali (Reuters Institute, IFJ) e indagini nazionali mostrano un lento miglioramento percentuale tra i top editor (da 23% nel 2020 a ~27% nel 2025), ma in Italia persistono numeri bassi per le direttrici dei principali quotidiani e delle testate tv.
Tre voci, tre prospettive
Vediamo in diretta il mondo del giornalismo da tre prospettive notando che solo nella mia autointervista è palese chi risponde. E' la necessità si celarsi dietro un nome fittizio già di per se la dice lunga.
La direttrice che non c’era, l'autointervista a me stessa, Nadia Fondelli direttrice di una testata on line
Qual è la barriera più difficile da superare per una donna che ambisce a dirigere una testata?
Non è una sola barriera, è una rete: stereotipi che ci vogliono più “morbide” nelle trattative, l’idea che il comando sia “maschile”, la mancanza di mentor. Ma conta anche il modello di lavoro che si richiede nel giornalismo: reperibilità continua e turni improvvisi che pesano se sei anche una donna di famiglia e magari madre. Ti chiedono sempre flessibilità in cambio spesso del niente.
La giovane freelance, nome di fantasia Giulia Bianchi
Lavorare freelance è una scelta di libertà o una trappola di precarietà per le giornaliste?
"Dipende. Il freelancing ti permette di avere spazio personale ma anche creativo e di visibilità, ma anche una notevole instabilità economica. Per molte giovani donne è l'unica via d’accesso: alla professione. Crei contenuti, costruisci una tua community ma rimane la sfida del riconoscimento economico e dei diritti, che non hai...
L'esperta, nome di fantasia Maria Rossi
Quanto conta la rappresentazione delle donne “esperte” nei media?
"Conta moltissimo. Quando le donne sono assenti come fonti autorevoli, la narrazione pubblica perde prospettive.
Le politiche editoriali che impongono quote di esperte nei talk e nelle rubriche funzionano. Non risolvono tutto, ma cambiano il tono del dibattito.