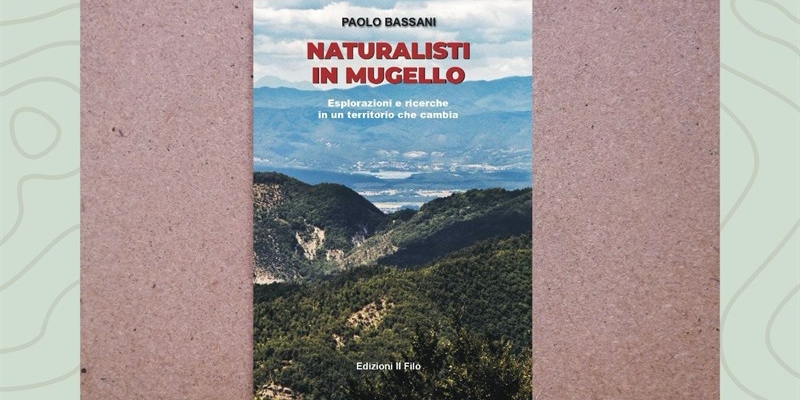Immagine di repertorio © Foto di OkFirenze
Immagine di repertorio © Foto di OkFirenze
Con questo articolo, Claudio Carpini, intende esplorare le dinamiche progenitrici di una certa forma di razzismo, ignoranza e superficialità che sembra dilagare oggi nella nostra società. Si tratta di un approfondimento che si svilupperà in vari articoli, in ognuno dei quali Carpini cercherà di analizzare cosa di vero si trovi dietro gli slogan che generano l'ignoranza così diffusa. Certi di non avere la verità in tasca, auspichiamo con questi articoli di poter sviluppare un dibattito e un confronto civile che ci possa permetta di progredire nella comprensione del nostro mondo.
IL CAPIRE ‘UN T’AMMAZZA
Non abbiamo il copyright di questa frase, che invece spetta ad un’anonima mano che ha scritto un cartello che fa bella mostra in un circolo nei dintorni d’Arezzo. Una frase, “Il capire ‘un t’amazza”, che è una delle più sintetiche e efficaci sintesi dei tempi attuali. E’ un invito ad andare oltre la simpatia, lo slogan, la battuta ad effetto e persino l’ideologia facile-facile, quella politicamente corretta (o politicamente scorretta: che alla fine è spesso l’altra faccia della stessa medaglia). Conformismo, scarsa propensione ad informarsi e, per conseguenza, trasformazione di tutti i temi più sensibili di questo momento in un coro da curva dominano tutti i dibattiti e non solo sui social. Ora: le curve degli stadi sono luoghi affascinanti. Ma quando sei in curva (e chi scrive qualche volta c’è stato) canti i cori che cantano tutti. E’ un livello di appartenenza dove il singolo si perde nell’insieme, dove nessuna distinzione è apprezzata più di tanto. I nostri tempi, politicamente parlando, sono così. Qualsiasi argomento viene trattato come se fosse tifo da stadio. Vaccini, lavoro, salute, destino dell’Europa, economia, immigrazione sono argomenti “terribili”, che richiedono una preparazione minima e un po’ di letture di base per poter esprimere un’opinione.
E invece no: o canti il mio coro, o canti quello degli avversari. Distinguo non se ne ammettono e ognuno di noi è chiamato a far capire chiaramente quale sciarpa che intende indossare. Nelle curve della politica, posizioni intermedie non sembrano poter esistere. Se mostri un interesse verso un punto di vista, automaticamente ti becchi un’etichetta. Perché ogni parte è convinta non solo di avere tutta e sola la verità in mano, ma che per conseguenza “gli altri” sono completamente nell’errore. Una visione assoluta del bene e del male che non solo non corrisponde alla realtà, ma impedisce anche di trovare soluzioni razionali ed efficaci. Perché i problemi di cui parliamo sono complessi, spesso collegati tra di loro da fili invisibili. Affrontarli per slogan non aiuta: l’eccessiva semplificazione porta a banalizzare, a leggere la realtà solo in modo superficiale. Pensare che tutto il bene sia da una parte e tutto il male dall’altra è un errore capitale dal quale però oggi non riusciamo a sottrarci.
Eppure dovremmo rifiutare questo modo di pensare: se guardiamo alla storia, anche quella recente, è evidente che se qualche volta (ma non sempre e quasi mai in tempo) abbiamo riconosciuto il male assoluto, è altrettanto chiaro che non ci è mai dato di individuare il bene assoluto. Il bene possibile, semmai e di tanto in tanto, come frutto più importante della politica vera, quella che è appunto l’”Arte del possibile”, secondo una definizione attribuita da Kissinger a Otto Von Bismarck. Così, si va avanti per slogan e etichette. Che dovrebbero provare la parte cha abbiamo scelto, individuare la nostra appartenenza. In questo modo, però, o si parla tra simili (e così giochiamo a darci ragione a vicenda), o ci si scontra senza possibilità di trovare punti di mediazione. E siccome in gioco è l’appartenenza e la conseguente delegittimazione dell’altro, non si va a fondo di nessun argomento, neanche quello più serio. Gli esempi si trovano a decine, ogni giorno, su qualsiasi piattaforma – dai social ai media tradizionali. Una deriva inarrestabile? Ci piacerebbe pensare di no.
E allora ci proviamo: parliamo di migranti, razzismo, integrazione. Con due avvertenze: la prima è che siamo consapevoli di toccare uno degli argomenti più sensibili di questi anni e che il rischio di essere etichettati da fascisti o da radical chic di sinistra è altissimo. Il secondo, è che non pretendiamo di dare risposte, ma semmai di provocare qualche curiosità e di spingere ad approfondire i tanti temi per farsi un’idea propria. Abbiamo anche pensato di utilizzare i principali slogan utilizzati da partiti e movimenti per andare oltre e porre le basi per una riflessione più solida. Per individuare i problemi, più che per cercare soluzioni. Il che è già un limite, ma fino a un certo punto: la soluzione dovrebbe essere nelle mani della politica.
“Aiutiamoli a casa loro”
Partiamo dunque dal primo slogan: “Aiutiamoli a casa loro”. Questa frase è slogan di destra, per definizione. Presuppone che potremmo evitare di avere un fenomeno migratorio così drammatico in Europa se solo promuovessimo il miglioramento delle condizioni di vita nelle regioni di origine. Dietro questo slogan, c’è un pensiero ragionevole: le persone fuggono dall’incertezza e dalla miseria per cercare condizioni di vita dignitosa alla quale è giusto e inevitabile possano aspirare. Promuovere iniziative volte a rimuovere le condizioni di miseria e disperazione è il primo passo per ridurre il flusso migratorio: si fugge dalle proprie radici quando la propria vita è in pericolo o quando non c’è più speranza per i propri figli. A sinistra, naturalmente, si mette in evidenza la contraddizione insita in questo pensiero: apparteniamo ad un continente che ha fatto del colonialismo la base per il proprio benessere, depredando a lungo le risorse di paesi africani, asiatici e americani.
Lo metteva in evidenza Roberto Saviano in un articolo del 26 luglio apparso sull’Espresso: la storia dell’Europa è anche quella del traffico di esseri umani dall’Africa al Nuovo Mondo, di negrieri che prima hanno spogliato l’Africa di uomini, poi hanno prosciugato le loro ricchezze. Saviano conclude meravigliandosi del fatto che l’Europa non senta il “dovere morale di accogliere”. Il tema, come dicevamo, è complesso e insidioso. Saviano ha certamente ragione a ricordare l’Europa ferocemente colonialista. Ma pecca su un punto: non tutti gli europei sono stati colonialisti nello stesso modo. Intendiamoci, noi italiani ci siamo fatti mancare nulla sotto questo profilo: magari siamo arrivati buoni ultimi, ma i nostri massacri li abbiamo combinati anche noi, nelle nostre avventure coloniali di fine Ottocento o nel Ventennio, quando anche all’Italia venne l’idea di avere un Impero. Francia, Inghilterra, Spagna e Germania hanno avuto però ben altro peso e ben altra forza: hanno esercitato il proprio pugno di ferro in modo ancora più violento e più prolungato. Acqua passata, si dirà. Per niente. La Francia, ad esempio, continua ad esercitare un’influenza enorme su 14 paesi africani, tenuti di fatto sotto scacco da scelte economiche e da un neocolonialismo economicamente distruttivo. Il sistema economico francese drena dall’Africa (oggi, non il secolo scorso) 500 miliardi di dollari ogni anno: è frutto di accordi commerciali capestro e addirittura di tasse coloniali imposte a paesi di per sé poverissimi come riconoscimento dei “benefici” ottenuti dai francesi durante il periodo coloniale. Ma gli stati africani non possono rinunciare a questi accordi? Certo che potrebbero.
Ma correndo qualche rischio. Il primo, è il trattamento che la Francia riservò alla Guinea quando questo stato africano dichiarò l’indipendenza, nel 1958. Prima di abbandonare il paese, l’amministrazione francese lasciò dietro di sé un cumulo di rovine: scuole ed edifici pubblici vennero dati alle fiamme e addirittura furono uccisi gli animali delle fattorie. Secondo aspetto è la presenza militare francese in Africa. Molto diminuita rispetto al passato, ma pur sempre rilevante e orientata a difendere gli interessi commerciali in Niger, in Costa d’Avorio, in Gabon. E in Libia, dove lo sciagurato intervento di Sarkozy ha destabilizzato una regione col solo obiettivo di promuovere la posizione di Total nelle commesse petrolifere. Terzo, ma molto collegato al secondo: la presenza militare ufficiale è accompagnata da quella non ufficiale. In mezzo secolo, i paesi dell’Africa francofona sono stati oggetti di numerosi colpi di stato che hanno visto abbattere regimi democratici per far subentrare dittature sanguinarie. E in molti casi, a guidare i colpi di stato sono stati ex soldati della legione straniera (come Bokassa nella Repubblica Centrafricana) o cadetti delle scuole militari francesi (come Kerekou, che prese il potere in Benin nel 1972). Rinunciare alla “copertura” coloniale francese rischia di generare collassi interni dei paesi africani. Possiamo aiutarli a casa loro, se in realtà sono i paesi africani che portano ricchezza? Difficile, a dire il vero, solo ipotizzarlo. I tedeschi non sono da meno, alimentando il contingente militare presente nel Sahel e anche noi italiani ci diamo parecchio da fare, se non altro vendendo armi e predisponendo un contingente militare in Niger.
Certo, per gestire i flussi migratori e in funzione di contrasto al terrorismo di matrice islamica. Ma anche per controllare che gli interessi di Eni vengano preservati. In sostanza, l’impressione è che la gestione dell’instabilità in Africa sia funzionale alla difesa degli interessi nazionali. Non ultimi quelli cinesi: negli ultimi anni, infatti, la Cina ha iniziato a rafforzare la propria presenza in Africa, con ingenti investimenti in infrastrutture. Ultimo esempio il Madaraka express, il treno finanziato interamente da Pechino che compie di quasi 500 chilometri tra Nairobi e Mombasa in circa cinque ore. Naturalmente, i cinesi sono tutto meno che filantropi: anche loro concorrono con gli europei alle risorse minerarie e petrolifere dell’Africa. Se gli interessi nazionali sono così forti, quindi, è possibile davvero “aiutarli a casa loro”? La risposta potrebbe venire dall’Europa. E tuttavia, l’incompiuta architettura europea mostra anche in questo caso tutti i propri limiti. Gli investimenti sono timidi: il Fondo Fiduciario per l’Africa ha messo a disposizione 1,8 miliardi di Euro, al quale si sono aggiunte le rimesse dei singoli stati membri. Per dare una dimensione, la sola Turchia riceve, per governare il flusso migratorio via terra lungo i Balcani – detto più chiaramente: per impedire che i migranti giungano in Europa via terra – 3 miliardi di euro. Vero che i paesi membri hanno contribuito al Fondo, versando complessivamente una cifra che ha portato il fondo a circa 3,2 miliardi di euro.
Ma anche in questo caso, gli interventi sono stati diversi e tradiscono i veri interessi neo-coloniali: perché se l’Italia ha versato 102 milioni (che sono niente rispetto ai circa cinque miliardi del complessivo sistema di accoglienza), la Francia ne ha versati appena 3. La tassa minima per sedersi al tavolo e contribuire comunque alle decisioni politiche. Per tornare allo slogan: potremmo aiutarli a casa loro, ma solo se rinunciassimo a parte dei nostri interessi. O meglio: se ci sedessimo al tavolo delle trattative da pari a pari, garantendo un sistema di aiuti in grado di sviluppare migliori condizioni di vita per la popolazione. Ma questo significa meno ricchezze per gli stati europei o almeno per alcuni di loro. Senza un’Europa forte, in grado di assorbire gli interessi dei singoli stati membri per valorizzare l’interesse comune, lo slogan rimane tale. Ma anche il “dovere morale dell’accoglienza” è un’illusione e un limite. Ripartiremo proprio da qui, nel prossimo articolo.
Alcune risorse (clicca sull'immagine per aprire l'articolo):
Galleria fotografica
http://www.africanews.it/14-paesi-africani-costret...